Note:
I COSTUMI
Quando Pietro mi ha chiamata e abbiamo parlato del film, ho percepito che per lui fosse importante non realizzare un film tradizionale su una delle figure più importanti del ‘900, ma immaginare qualcosa che avesse a che fare con un’atmosfera, una sensazione o un quadro pittorico, piuttosto che con una ricostruzione storica esatta. Mi sono recata alla Fondazione Cini a Venezia, che conserva il più grande archivio di documenti relativi all’attrice. È una documentazione preziosa composta da lettere, fotografie, oggetti e anche alcuni dei suoi abiti, sia di scena che di vita, per iniziare a conoscerla. È stato emozionante vedere alcuni dei suoi straordinari vestiti firmati Mariano Fortuny o Worth e lasciarsi ispirare da essi.
Un altro luogo fondamentale è stato il Museo Fortuny, con il suo allestimento magico e teatrale di tessuti, abiti e attrezzi. Lì ho potuto vedere i costumi autentici che Mariano Fortuny aveva creato esclusivamente per Eleonora Duse.
Il film racconta l’ultimo periodo di vita dell’attrice, nell’immediato dopoguerra, e il suo tentativo di rilanciare la compagnia, nonostante le difficoltà economiche e la malattia. All’inizio del film, lei è una vedova di guerra, vestita di nero con il velo, che si reca a trovare i soldati al fronte per offrire conforto.
In questa prima parte si avverte ancora il dolore e la distruzione della guerra, anche attraverso i costumi scuri e modesti.
Quando Eleonora Duse decide di rilanciare la compagnia teatrale tornando a Venezia, ritrova slancio e colore nella propria vita. La vediamo più eccentrica, con un grande cappello decorato con fiori e un mantello dal colletto importante, che le incornicia il viso facendola apparire quasi come un’apparizione. I colori ritornano, in particolare il blu, che richiama Venezia, i suoi canali e la pittura.
Leggendo un documento di Doretta Davanzo Poli, che descrive il modo di vestire della Duse, si apprende che: “Pare che l’abbigliamento della Duse durante la giornata fosse trasandato: cappelli di traverso, lunghi mantelli, veli lenti, bluse mal abbottonate, gonne male agganciate, un guanto su e uno giù, indifferente al giudizio di tutti.”
Questo documento descrive bene un tratto distintivo della sua personalità. Non la troviamo mai vestita in modo impeccabile, ma piuttosto con un’eleganza disordinata.
Spesso, negli attori e nelle attrici, non esiste una netta separazione tra la vita e il teatro, tra i costumi di scena e gli abiti quotidiani. Anche nella vita, la Duse indossava lunghe tuniche fluide, proprio come in scena, con una semplicità rigorosamente spoglia. Spesso era senza ornamenti, senza volant, senza gioielli e, persino in scena, senza parrucca. In questa sua semplicità si avverte l’influenza della moda riformata e dello stile liberty, che possiamo ritrovare anche nelle tuniche fluide e ampie degli artisti come Klimt e nella moda delle Wiener Werkstätte.
Per gli spettacoli, la Duse aveva idee molto chiare: non tanto sulla foggia dei costumi, quanto piuttosto sui colori, essenziali per creare un’atmosfera, una sensazione, un simbolismo profondo.
In un documento relativo a “La donna del mare” di Ibsen, si sottolinea l’importanza di un particolare blu per il costume della protagonista: il blu del mare del Nord, il blu di Edward Munch, un blu con riflessi d’argento e grigio.
Per “La città morta” di D’Annunzio, invece, immaginava costumi ispirati alle vesti antiche, con tonalità avorio, crema e bianco.
È interessante notare la differenza tra le due compagnie teatrali più famose dell’epoca, quella di Eleonora Duse e quella di Sarah Bernhardt. La compagnia della Duse aveva qualcosa di antico, mai alla moda, con gonne lunghe e grandi scialli, caratterizzata da una semplicità essenziale. Al contrario, la compagnia della Bernhardt era vestita all’ultima moda, più rumorosa e variopinta.
Ursula Patzak
LE SCENOGRAFIE
“Navigare nella follia di una costruzione creativa”
Per il film è stato svolto un lavoro di grande ricerca, spaziando tra passato, presente e futuro, applicando tali influenze nelle sue diverse forme, insieme a Pietro, agli sceneggiatori e ai reparti creativi. In particolare, con Pietro abbiamo cercato di approcciare il film in modo estremamente realistico, curando con attenzione ogni più piccolo dettaglio, inserito con equilibrio nello spazio affinché rispecchiasse nella sua interezza la realtà racchiusa in esso.
La “verità” poetica delle scelte stilistiche e scenografiche si esprime attraverso la luce, che riflette uno sguardo reale e consapevole, delineando anche il carattere dei personaggi in una vera e propria sfida all’autenticità. È come se ogni dettaglio fosse composto da pennellate piccole e ravvicinate, quasi trasparenti, uniche nella loro mescolanza con colori vividi e tinte pure. La visione prospettica è determinata dal flusso della luce diegetica, che si riflette sugli oggetti all’interno dell’inquadratura, modulata in base all’effetto reale prodotto dai materiali in natura.
“Altri pittori dipingono un ponte, una casa, una barca... io voglio dipingere l’aria che circonda il ponte, la casa, la barca, la bellezza della luce in cui esistono”.
(Claude Monet).
In generale, l’approccio al film è stato concepito come un flusso luminoso di rifrazione sulle diverse forme e colori, generando un’immagine poetica che attraversa diverse influenze artistiche: dal realismo all’impressionismo, fino al barocco. Le mie fonti di ispirazione nella pittura spaziano da Monet, Vermeer, Renoir, Courbet, Fattori, Borrani e Morandi; mentre nel cinema, mi sono ispirato a Tarkovskij, Visconti, Losey e Truffaut.
Tutti gli ambienti sono stati costruiti o riadattati lavorando su piante specifiche e su precise scelte di inquadratura. Dalle scene di battaglia agli interni, ogni elemento è stato pensato con una visione più ampia, grazie anche all’uso del set extension. La palette cromatica che accompagna il film utilizza colori puri e si attenua nelle scene in esterni, valorizzando i cieli nelle aperture.
Per molte vedute ampie e transizioni, abbiamo ricostruito delle miniature dichiaratamente in scala ridotta, poi ricreate anche in scala reale, un motivo ricorrente nel film che ci riporta sempre nel mondo poetico di Eleonora. Dietro ogni forma e scelta scenografica si cela un significato più profondo, che non è solo decorativo, ma accompagna la narrazione, sia in modo esplicito sia in maniera più sottile. Un esempio emblematico è una scena in cui Eleonora racconta una favola ai suoi nipoti, che, nel corso della loro vita, non hanno mai visto la nonna a teatro, nemmeno sua figlia. Per questa sequenza abbiamo ricreato un letto a baldacchino che richiama la bocca di scena di un teatro, ed è in quel momento di racconto che assistono realmente anche se per pochi minuti, a chi fosse la grande Duse.
Gaspare De Pascali
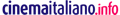 :
: